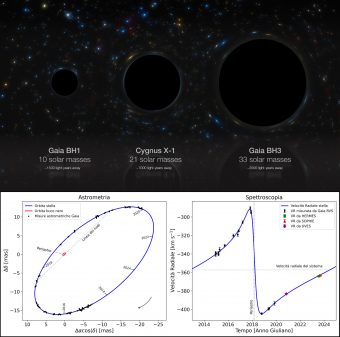8 Febbraio, Stratfor Global Intelligence
Gli stati ex-sovietici dell’Europa orientale Ucraina, Bielorussia e Moldavia sono importanti per la Russia per vari motivi, tra cui l’ubicazione geografica e le relazioni economiche. In genere, tutti questi stati cooperano con Mosca, ma i gradi di cooperazione variano. L’Ucraina comprende la necessità di forti legami con la Russia, ma lavora per giocare tra la Russia e l’Occidente per ottenere il maggior numero possibile di concessioni. La Bielorussia, in gran parte isolata dall’Occidente per motivi politici, dipende molto dalla Russia ed è già membro dell’unione doganale di Mosca con il Kazakhstan, quindi sarà meno resistente alla integrazione nell’Unione eurasiatica. La Moldavia è un paese diviso all’interno, trascinato da una parte verso le potenze occidentali e dall’altra parte verso Mosca, ed è destinato a rimanere politicamente paralizzato per il breve e medio termine.
Ucraina
Diversi fattori rendono l’Ucraina cruciale per la Russia. La sua posizione sulla pianura del Nord Europa e lungo il Mar Nero, ha fatto dell’Ucraina un percorso tradizionale per l’invasione da ovest. L’Ucraina è anche il secondo paese più grande dell’ex Unione Sovietica in termini di popolazione. Inoltre, l’Ucraina è la terza più grande economia dell’Unione Sovietica, e le sue industria, agricoltura ed energia sono integrate con quelle della Russia.
Le Leve della Russia
● Politica: il presidente ucraino Viktor Janukovich e il suo Partito delle Regioni godono di una relazione di sostegno con Mosca. La Russia ha anche legami con i leader dell’opposizione ucraina come l’ex primo ministro Julija Timoshenko e il politico di spicco Arsenij Jatsenjuk. Inoltre, gli oligarchi ucraini, come Dmitrij Firtash e Rinat Akhmetov, hanno mantenuto relazioni commerciali con la Russia.
● Sociale: i cittadini di origine russa rappresentano il 17 per cento della popolazione ucraina, e il 30 per cento degli ucraini parla russo come lingua madre. Inoltre, gli ucraini provengono dallo stesso gruppo etnico-linguistico slavo orientale dei russi (e dei bielorussi). La maggior parte del paese è cristiana ortodossa, e oltre il 10 per cento della popolazione ucraina è sotto il patriarcato di Mosca.
● Sicurezza: La Russia mantiene una presenza militare in Ucraina, stazionando la sua Flotta del Mar Nero in Crimea. Il servizio di sicurezza federale della Russia e il suo omologo ucraino collaborano nell’intelligence e nell’addestramento. Anche se l’Ucraina non è un membro dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO) guidata dalla Russia, non è neanche un membro della NATO.
● Economica: l’Ucraina ottiene più del 60 per cento del suo gas naturale dalla Russia, con cui può manipolare l’infrastruttura delle pipeline ucraina, tagliandone i rifornimenti. La Russia possiede molte risorse nel settore dell’industria metallurgica dell’Ucraina e rifornisce l’energia all’industria (oltre a mantenere rapporti commerciali con gli oligarchi del settore). La Russia fornisce all’Ucraina anche assistenza finanziaria o prestiti tramite la Sberbank e altre istituzioni finanziarie.
Successi, ostacoli e ambizioni della Russia
Tra il 2010 e il 2012, la Russia ha raggiunto molti dei suoi obiettivi in Ucraina. Mosca ha esteso il contratto di affitto di Sebastopoli per la Flotta del Mar Nero fino al 2042. La legislazione ucraina ha reso illegale l’appartenenza alla NATO, limitando i legami di Kiev con il blocco, e la fazione filo-occidentale del governo ucraino, guidata dall’ex presidente Viktor Jushchenko e il suo partito Nostra Ucraina-Autodifesa popolare sono stati emarginati. Una grave minaccia per i piani della Russia, gli accelerati negoziati tra Kiev e l’Unione europea, non sono stati completati nel 2011 come previsto, lasciando Ucraina senza accordi di associazione e di libero scambio con l’Unione e senza prospettive esplicite di adesione all’UE.
Nel 2012, Mosca spera di ottenere un certo grado di controllo sulle pipeline e sul sistema di immagazzinamento energetici dell’Ucraina, mantenendo elevati i prezzi del gas naturale e costringendo l’Ucraina a scambiare risorse energetiche con un gas più economico. La Russia vuole anche impedire che l’Ucraina si avvicini troppo all’Unione europea attraverso la creazione e la manipolazione di sfide interne che non mancheranno di tenere occupato Janukovich, e rendere l’Ucraina meno desiderabile agli europei. Inoltre, Mosca prevede di impedire a specifici stati membri dell’UE, in particolare Svezia e Polonia, e alla loro iniziativa di Partnership orientale, dal concentrarsi sull’Ucraina, mantenendo quei paesi divisi e concentrati su altre questioni.
Tuttavia, questo non significa che Mosca può fare quello che vuole in Ucraina. La più grande sfida alle ambizioni della Russia in Ucraina proviene dal governo ucraino, nonostante gli stretti legami del governo con Mosca. Non è nell’interesse di Janukovich o degli oligarchi che compongono la sua base di potere, cedere il controllo del sistema di transito del gas del Paese alla Russia, che non è solo una risorsa economica di vitale importanza, ma anche un simbolo della sovranità dell’Ucraina. È per questo che l’Ucraina ha continuato ad opporsi a vendere il sistema alla Russia e ad entrare nelle istituzioni guidate dai russi, come l’unione doganale, che minerebbe ulteriormente la sovranità economica di Kiev.
Oltre il 2012, Mosca vuole preparare l’Ucraina a una maggiore integrazione attraverso l’adesione all’Unione Eurasiatica, evolventesi in unione doganale e spazio economico comune.
La posizione e la strategia dell’Ucraina
Poiché storicamente è stata governata da molte potenze estere – Russia, Polonia, Austria-Ungheria e Impero Ottomano, – il territorio che costituisce la moderna Ucraina comprende popoli provenienti da culture diverse e con diverse visioni del mondo. La divisione più ampia in Ucraina è tra l’est, economicamente e culturalmente più integrato con la Russia, e l’ovest, più nazionalista, più vicino all’occidente e più favorevole all’adesione dell’Ucraina alle istituzioni occidentali, come l’Unione Europea. L’imperativo principale per ogni Stato ucraino è evitare che il paese si spacchi ed essere in equilibrio tra le potenze straniere per mantenere la sovranità.
Così, Janukovich, nonostante provenga dall’est dell’Ucraina e sostenga una piattaforma molto più amichevole verso la Russia di quella del suo predecessore, non è stato solo un alleato incondizionato di Mosca, durante la sua presidenza. Anche se ha fatto numerosi gesti favorevoli alla Russia, all’inizio del suo mandato, come passare la normativa giuridica per bloccare l’adesione alla NATO e la firma dell’accordo Gas – Flotta del Mar Nero, Janukovich ha poi cercato di bilanciarli con i negoziati dell’Ucraina con l’Unione europea, per firmare l’accordo di associazione e libero scambio (con cui Kiev spera di includere una disposizione per un’eventuale adesione all’UE).
Tuttavia, il fallimento dei negoziati dell’Ucraina con l’Unione europea, a causa della detenzione della Timoshenko, ha indebolito il contrappeso dell’Ucraina verso la Russia e costretto Kiev a una posizione difficile. L’Ucraina può soltanto cercare di pagare più di 400 dollari ogni mille metri cubi di gas della Russia, per un tempo sufficiente lungo, prima che i prezzi alti creino una crisi finanziaria; così si tratta davvero della questione di quando – e non se – l’Ucraina dovrà dare alla Russia almeno un certo controllo, o l’accesso al suo sistema energetico, in cambio di prezzi più bassi. Questo diminuirà la capacità di Kiev di manovrare ulteriormente nei confronti di Mosca, e farà in modo che, lo voglia o no, l’Ucraina infine debba tenere in conto gli interessi della Russia.
Bielorussia
La geografia gioca un grande ruolo nell’importanza della Bielorussia per la Russia. Il paese è situato sulla pianura nord europea, un percorso tradizionale d’invasione da ovest, e non ci sono barriere geografiche significative agli invasori, a causa del terreno pianeggiante del paese. La Bielorussia funge da tampone per il nucleo territoriale della Russia. La Bielorussia ha anche una delle maggiori economie dell’ex Unione Sovietica, e le sue industrie, energia e sicurezza sono integrate con quelle della Russia.
Le Leve delle Russia
● Politica: la Bielorussia e la Russia sono partner nello Stato dell’Unione, e il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko riceve il sostegno di Mosca. La Russia ha legami con i leader della sicurezza bielorussa e l’élite economica della Bielorussia ha rapporti d’affari con la Russia.
● Sociale: i cittadini di origine russa rappresentano l’11 per cento della popolazione bielorussa. La maggior parte della popolazione bielorussa parla il russo come lingua madre, e il russo e il bielorusso sono entrambe lingue ufficiali del paese. La maggior parte del paese è cristiana ortodossa, con circa il 60 per cento della popolazione sotto il patriarcato di Mosca. Bielorussi e russi hanno radici nello stesso gruppo etnico-linguistico slavo orientale e quindi hanno affinità culturali.
● Sicurezza: il complesso militare-industriale della Bielorussia è integrato con quella della Russia, e i due paesi hanno un sistema unificato di difesa aerea. La Bielorussia è un membro della CSTO a guida russa e ospita installazioni militari russe, come i sistemi di difesa aerea S-300. Inoltre, gli organismi d’intelligence bielorussi e russi hanno un rapporto di collaborazione, compresa l’addestramento.
● Economica: La Russia fornisce il 99 per cento del gas naturale della Bielorussia e la maggior parte del suo petrolio. La Russia possiede anche una quota del 100 per cento di Beltransgaz, dandogli la piena proprietà dei gasdotti del paese. Gli scambi commerciali tra i due Paesi sono importanti per l’economia bielorussa, la metà delle esportazioni bielorusse va in Russia. Inoltre, la Russia fornisce alla Bielorussia assistenza finanziaria, tra cui un prestito di 3 miliardi dollari attraverso la Comunità economica eurasiatica, e 1 miliardo di dollari di prestito dalla Sberbank.
Successi, ostacoli e ambizioni della Russia
L’influenza della Russia in Bielorussia non è stata incontrastata negli ultimi due anni. All’inizio del 2010, Lukashenko s’è scagliato contro Mosca per gli elevati prezzi dell’energia e ha iniziato a prendere in considerazione fornitori alternativi (Venezuela e Azerbaigian, in particolare), come modo per fare pressione sulla Russia ad abbassare i prezzi. Ma la Russia ha mantenuto alti i prezzi e tagliato il gas naturale alla Bielorussia, fino a quando Minsk ha accettato di cedere il controllo completo del proprio sistema di pipeline e di Beltransgaz a Mosca.
La Russia ha seguito diverse strategie per aumentare la sua influenza in Bielorussia. A partire dal 2010, Russia e Bielorussia si sono integrate economicamente e la Bielorussia ha aderito all’unione doganale russa, una entità che è diventata lo Spazio economico comune nel 2012. La Russia è stata in grado di limitare i legami verso occidente della Bielorussia e le aperture, attraverso la Polonia, dell’UE a Minsk, in vista delle elezioni bielorusse. Dopo le elezioni, l’Occidente ha scelto di isolare la Bielorussia, dando alla Russia la possibilità di aumentare il suo sostegno economico e politico a Lukashenko. Mosca ha anche migliorato la sua integrazione della sicurezza con Minsk, quando la Bielorussia ha aderito alla forza di reazione rapida della CSTO e ospitato lo schieramento di S-300.
Nel 2012, la Russia vuole proseguire i suoi sforzi di integrazione della Bielorussia. Lo spazio economico comune servirà gli interessi economici della Russia, ma Mosca vuole accedere agli asset economici più strategici della Bielorussia, quali le raffinerie e l’azienda dei sali di potassio Belaruskali. Politicamente, Mosca vuole che Minsk rimanga isolata dall’Unione europea e dall’Occidente. Militarmente, la Russia vuole utilizzare le vendite di armi e la partecipazione alla CSTO per avvicinare la Bielorussia. Dopo il 2012, la Russia vuole una completa integrazione strategica della Bielorussia, attraverso l’Unione Eurasiatica.
Posizione e strategia della Bielorussia
A differenza della Russia o dell’Ucraina, la Bielorussia è una società relativamente omogenea, sia culturalmente che politicamente. Questo ha facilitato la centralizzazione del potere di Lukashenko, che domina politicamente la Bielorussia dal 1994. Inoltre, a differenza della Russia o dell’Ucraina, la Bielorussia non ha sviluppato una potente classe di oligarchi; piuttosto, Lukashenko ha mantenuto un modello sociale ed economico molto simile al vecchio sistema sovietico, sin dai primi anni dell’indipendenza della Bielorussia. Governa il paese con un affiatato gruppo di élite, molti dei quali hanno legami con l’apparato di sicurezza e d’intelligence.
Anche se questa dinamica ha reso più facile il consolidamento del potere, complica un altro imperativo: l’equilibrio tra le potenze straniere per mantenere la sovranità economica, militare e politica.
La Bielorussia non si è mai allontanata troppo dalla Russia in termini di sicurezza o economia, tenuto conto dei requisiti delle riforme democratiche ed economiche necessarie per essere considerati membri della NATO e dell’UE. Tuttavia, i rapporti politici della Bielorussia con la Russia non sono stati così costanti, i due paesi hanno formato lo Stato dell’Unione nel 1997, ma questa vicinanza non ha impedito divergenze sulle questioni economiche che hanno portato periodicamente Lukashenko a guardare verso Occidente per la cooperazione, al fine di ottenere una leva sulla Russia. Data l’integrazione delle infrastrutture della Bielorussia con quelle della Russia, e le connotazioni politiche delle relazioni economiche, questo è più facile a dirsi che a farsi. I test di Minsk su Mosca su questioni quali i prezzi dell’energia, di solito sono fallite, come la recente acquisizione da parte di Gazprom di Beltransgaz ha dimostrato.
Paesi come la Polonia e la Lituania hanno interessi geopolitici nel corteggiare la Bielorussia, come il desiderio di stabilire ad est lo stesso tipo di tampone territoriale che la Russia desidera avere da ovest. Ma questi paesi non possono eguagliare l’influenza della Russia sulla Bielorussia, così hanno fatto ricorso a manovre di soft power, come la creazione di legami con gruppi di opposizione bielorussi e guidato sanzioni dell’UE contro il governo Lukashenko. Il successo della prima strategia è stato limitato, dal momento che i gruppi di opposizione affrontano numerosi vincoli. La seconda strategia è una minaccia più grave per il governo bielorusso, in quanto il governo di Lukashenko dipende da un modello populista economico e tali modelli s’indeboliscono in ambienti economicamente e finanziariamente poveri. Tuttavia, questo isolamento economico ha dato alla Russia la possibilità di fornire assistenza finanziaria e servire come ancora di salvezza economica della Bielorussia, un ruolo che Mosca continuerà a giocare per tutto il tempo in cui Lukashenko sarà sulla cresta dell’onda.
Andando avanti, la Bielorussia non avrà altra scelta, se non supportare la strategia e una più ampia rinascita della Russia, date le limitate opzioni di Minsk di ottenere sostegno da altre potenze. Pertanto, la Russia continuerà a integrare la Bielorussia, muovendosi verso la creazione dell’Unione Eurasiatica nel 2015.
Moldova
La posizione della Moldova la rende importante per la Russia. Si trova nella Bessarabia, tra i Carpazi e il Mar Nero, un percorso tradizionale d’invasione da sud-ovest e dagli Stati balcanici. Si trova vicino al porto strategico di Odessa e alla penisola di Crimea, dove la Russia staziona la sua Flotta del Mar Nero, e serve come parte della rete di transito dell’energia che collega la Russia all’Europa e alla Turchia.
Le leve della Russia
● Politica: L’ex presidente moldavo Vladimir Voronin e il suo partito comunista si trovano in partnership con la Russia. Mosca ha anche legami con i leader dell’Alleanza per l’Integrazione Europea (AEI), tra cui il primo ministro moldavo Vlad Filat e il presidente Marian Lupu. In particolare, la Russia sovvenziona la leadership della regione secessionista della Transnistria.
● Sociale: solo circa il 6 per cento della popolazione moldava è etnicamente russa, anche se in Transnistria il 30 per cento della popolazione è russa (e un altro 30 per cento è ucraino). Circa l’11 per cento dei moldavi parla russo come lingua madre, e circa il 16 per cento della popolazione ha il russo come lingua primaria. La maggior parte del paese è cristiana ortodossa, ma divisa tra ortodossa rumena e ortodossa russa.
● Sicurezza: La Russia mantiene circa 1.100 truppe in Transnistria (insieme ad un piccolo contingente di soldati ucraini). Anche se la Moldavia non fa parte del CSTO a guida russa, non è neanche membro della NATO.
● Economica: la Moldova dipende dalla Russia per il 100 per cento del gas naturale e invia il 20 per cento delle sue esportazioni in Russia (particolarmente importante è il vino, importazione che la Russia ha tagliato per ragioni politiche). La Russia controlla gran parte dell’economia in Transnistria – che pur essendo una regione separatista, è il cuore industriale della Moldova – e fornisce assistenza finanziaria e sovvenzioni alla Transnistria.
Successi, ostacoli e ambizioni della Russia
La Russia ha respinto i tentativi di smilitarizzare la Transnistria o consentire una presenza occidentale sul suo territorio. Tuttavia, Mosca ha dovuto fronteggiare alcune battute d’arresto in Moldova; i comunisti non sono al potere da quando il filo-occidentale AEI li ha cacciati dal potere nel 2009, dopo la “Rivoluzione Twitter”. Nonostante la sua posizione, l’AEI non è abbastanza forte da eleggere un presidente, per cui la Moldova è in stallo politico da quasi tre anni.
Gli obiettivi della Russia per il 2012 sono migliorare la propria posizione in Moldova, attraverso il rafforzamento del Partito comunista e formando relazioni indipendenti con i leader e i membri dell’AEI. Se la Russia non può aiutare i comunisti a riconquistare il potere, almeno vuole far rimanere divisa la Moldova e l’AEI incapace di eleggere un presidente filo-occidentale. Mosca potrebbe ottenere questo risultato complicando il processo politico e ostacolando i negoziati tra Moldavia e Transnistria. La Russia vuole anche mantenere la propria presenza militare e influenza politica in Transnistria, e iniziare a gettare le basi per un eventuale inserimento della Moldova nell’Unione Eurasiatica.
La posizione e la strategia della Moldova
Come l’Ucraina, la Moldova è sia debole che divisa. A differenza dell’Ucraina, la Moldova non ha legami tradizionali o etnici con la Russia, è rumena etnicamente e linguisticamente. Questo, insieme alla piccole dimensioni e allo scarso peso strategico della Moldava, è un fattore principale della debolezza dello Stato e della sua capacità di essere in equilibrio tra le potenze straniere.
La Moldova è divisa sia territorialmente che politicamente. Il governo moldavo non detiene la sovranità territoriale sulla Transnistria, che ospita una base militare russa ed è popolata in gran parte da russi e ucraini. La spaccatura all’interno della Moldova è politicamente dominata da due grandi gruppi: i comunisti filo-russi e la AEI, una coalizione di partiti che vogliono portare la Moldova verso occidente. L’AEI si articola ulteriormente, con alcuni elementi impegnati in stretti legami con la Romania e la NATO, mentre altri sono più flessibili nelle loro lealtà, ma in generale, tutti i partiti dell’AEI supportano l’integrazione moldava con l’Unione europea. Dal 2009, né il Partito comunista, né l’AEI sono in grado di ottenere abbastanza voti in parlamento (61 su 101) per eleggere un presidente, in modo che il paese è paralizzato e incapace di formare una politica estera decisiva da quasi tre anni. Queste divisioni significano che la visione e la strategia della Moldova non sono unificate. Tutti i leader della Moldova devono superare queste divisioni, al fine di consolidare il paese, solo allora la questione della Transnistria e le più ampie questioni di politica estera, saranno affrontate da Chisinau.
Potenze straniere, oltre alla Russia, hanno interessi in Moldova; prima fra tutte la Romania. Non solo la Moldova e la Romania condividono legami etnici e linguistici, ma anche il territorio che costituisce la Moldova e la Transnistria (così come parti occidentali dell’Ucraina) appartenevano alla Romania, come provincia di Moldavia, prima che la Russia annettesse il territorio come baluardo difensivo. Tuttavia, la Romania non è abbastanza forte per sfidare la Russia militarmente, e dato che la Moldova è il paese più povero d’Europa ed è sostanzialmente limitato dalla presenza e dall’influenza della Russia, le prospettive di adesione all’UE, nel vicino a medio termine, sono assai improbabili (anche se la distribuzione di passaporti rumeni ai cittadini moldovi, che gli permette di viaggiare nell’Unione europea, è un esempio di soft power della Romania verso il paese). Altri singoli stati membri dell’UE come la Polonia e la Svezia, vogliono avvicinare all’occidente la Moldova attraverso il programma di partenariato orientale, ma questo è un processo a lungo termine dagli effetti limitati.
La paralisi della Moldavia – politico, territoriale e geopolitica – dovrebbe persistere fino a che una potenza straniera sarà in grado di contestare la Russia nella regione in termini di hard power, piuttosto che soft power. Questo non è probabile che accada nel breve e medio termine.
FONTE: http://www.stratfor.com/analysis/next-stage-russias-resurgence-ukraine-belarus-and-moldova
Traduzione di Alessandro Lattanzio
http://sitoaurora.altervista.org/home.htm
http://aurorasito.wordpress.com
![Share on Facebook Facebook]()
![Share on Google+ google_plus]()
![Share on Reddit reddit]()
![Pin it with Pinterest pinterest]()
![Share on Linkedin linkedin]()
![Share by email mail]()
![Share on Facebook Facebook]()
![Share on Google+ google_plus]()
![Share on Reddit reddit]()
![Pin it with Pinterest pinterest]()
![Share on Linkedin linkedin]()
![Share by email mail]()